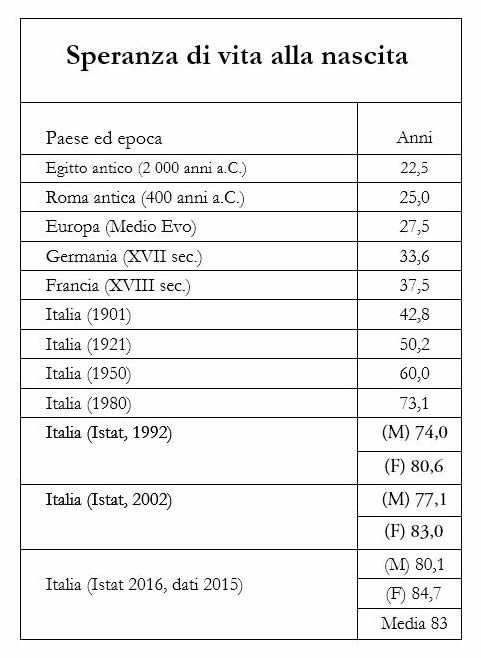Fattori neurobiologici, psicogenetici e psicosociali dell’aggressività e della violenza
Parte prima
L’aggressività e la violenza secondo la filosofia, i naturalisti, la psichiatria, la psicanalisi, il comportamentismo e l’etologia
Per aggressività si intende l’inclinazione di un organismo vivente a sviluppare comportamenti offensivi nei confronti di altri organismi viventi, che possono raggiungere un’intensità tale da provocarne la morte. Si tratta di una caratteristica del mondo animale, di cui l’uomo fa indubbiamente parte, che spinge l’aggressore verso comportamenti orientati ad appropriarsi di un altro organismo vivente ai fini della propria nutrizione o ad affermare il potere di dominio e di difesa del proprio territorio o ad avere la supremazia all’epoca degli amori: l’aggressività può essere quindi predatoria, da difesa e da competizione sessuale.
Da Conrad Lorenz l’’aggressività è definita come la pulsione combattiva diretta contro i membri della stessa specie, tanto negli animali quanto nell’uomo.
Secondo il World report on violence and health (Geneve 2002), la violenza umana è sinonimo di prepotenza, angheria, brutalità, prevaricazione ed esprime l’uso intenzionale di forza fisica o di potere, minaccioso o reale, contro una persona o un gruppo di persone o una comunità, che comporta o ha una alta probabilità di comportare lesioni fisiche, morte, danno psicologico, e/o deprivazione.
La violenza può essere fisica o verbale, in quanto si può attuare con atti di aggressione fisica rivolti a provocare lesioni più o meno gravi o con modalità verbali e/ o gestuali, volte ad offendere, umiliare tratti caratteristici della personalità altrui, come il sentimento di libertà o il sentimento di autostima e di dignità.
Negli animali predatori, la violenza è regolata sia dall’apparato della vita di relazione, costituito da organi con cui l’animale si mette in contatto con l’ambiente esterno (organi sensitivo-sensoriali e del sistema nervoso centrale) sia dall’apparato osteo-artro-muscolare, preposto ai movimenti del corpo nello spazio e dei suoi segmenti tra di loro.
Nell’uomo, il cervello, l’organo preposto all’interpretazione degli stimoli e all’elaborazione della relativa risposta, essendo particolarmente sviluppato, risulta provvisto della proprietà di contenere l’aggressività ovvero di poterla tradurre in comportamenti violenti.
Prima ancora che i cultori della scienza della natura e dei fenomeni sociali studiassero scientificamente l’aggressività e la violenza, Hobbes e Rousseau furono i più autorevoli filosofi che hanno teorizzato il comportamento originario dell’uomo.
Secondo la teoria di Thomas Hobbes (1588-1679), esposta nel “Leviatano” (1651), il comportamento dell’uomo allo stato di natura è dominato dall’aggressività e dalla violenza.